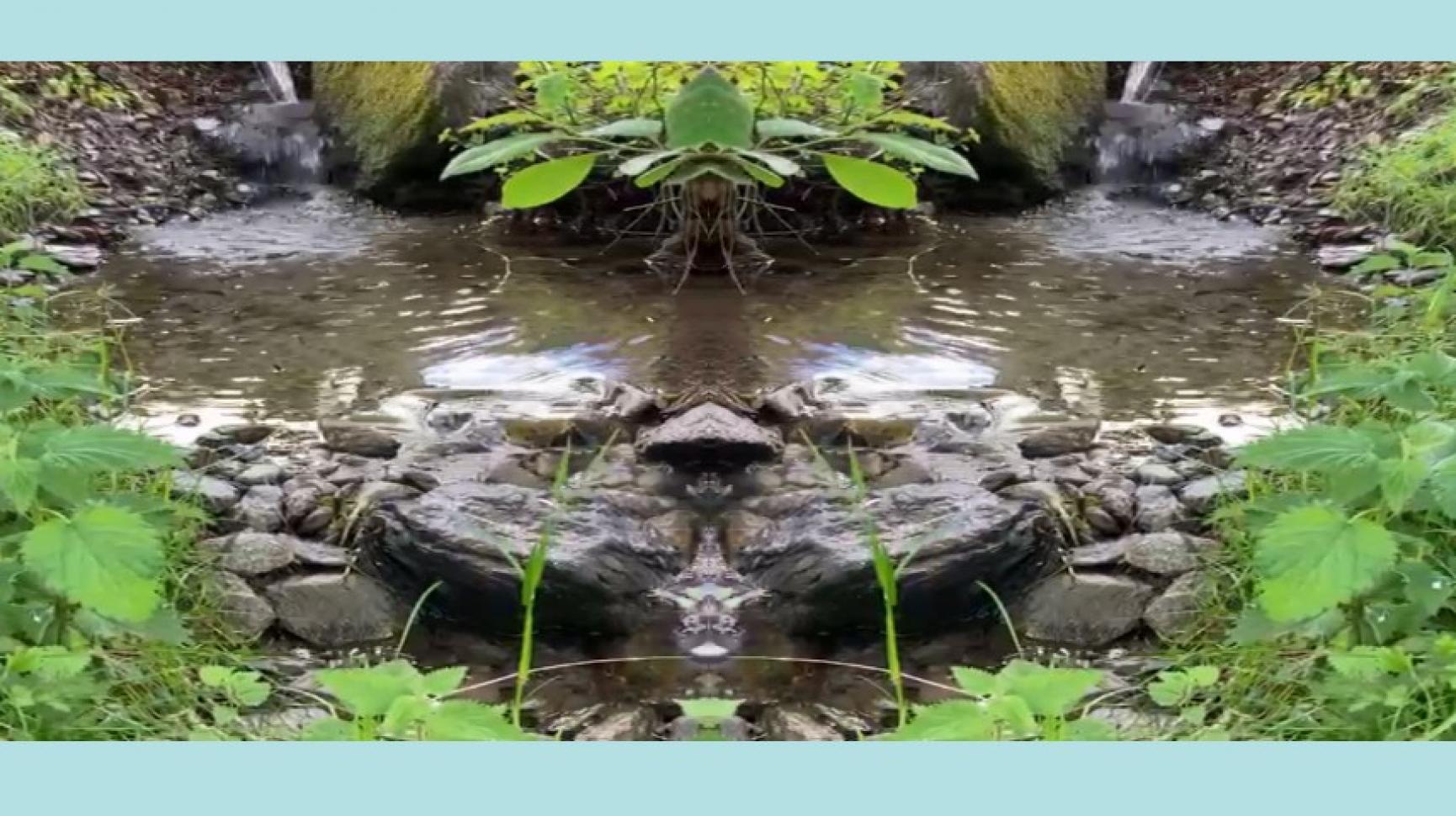
Ol bósch èn quarantena
di Anna Gherardi - Paese delle Storie 2020
Ol bósch èn quarantena
Li vàchi li pascóola trà li Piani e l'Aial dèla Caòra. Animai bei gròs simpatèch da idìi 'ndèl bósch di cólóor.
Daparlóor li torna àla masù par fàs muisc.
'Na quai manzèta la 'ndava 'mpóo nüscia.
Nùu bagài cóma, pìscen Tarzan, am sè tacava sü ai ràm bàs di làres e me ulava par pò tufàs, sensa pura, trà cèrfói dei malacrìi.
Ol 23 feorèer 2020 'l saltafó l'emèrgensa dol curùna virus.
La debolèza e l' impotensa ai sciopafò 'ndèla nòsa vìta e nùu an sè frastornac'.
Ol dolóor e la mòrt li me pàsa visìni, parèec’ e amìis ai se màala, vargüu ai mṍr e 'n pö ca 'ndàa a truai gné compagnai gnè 'n gésa gnè al cimiteri. Am sè cunfinàac' èn cà, sensa pudìi fàa tàat, se pó piscì léisc 'n quai libro.
Maravéia e compaśiù i'mpinìs li cà, i óspedài, i obitori, li cà de cura e li stràdi ṍidi deli cità e di paées.
Ol bósch l'è 'n paées dèla 'maginaziù ca la divènta véra.
Am fà a regàta a scirnìi ol tösch dè castàa pǜsé grànt par fàité la nòsa cà da pudìi giügàa.
Tóchei dè piàc', strèdoli dè védro coloràat, scàtoli dè làta, cocóni e sàs dali fórmi strani iè li nòsi róbi de cà.
Am rèmasü tòchei de legn e an ghè fà la scésa 'ntóren a 'n òrt pìscen.
La tèera dè castàa l'è bùna e cóma par màgia i trìi faśṍi sómnàac' i bütàa e ai rampéga sǜ 'ndèla fràsca.
Véc’ ségn còla mèla e ol gióen tochèl de nisciolèer 'l divènta 'na pupulina; mè la vistìs coli fói làrghi dè castàa taiadi e cüśìdi coi fìi-i de èrba e decorac' de tèndri fióor dèla sèlva.
La televisiù l'è tròp pìza e la trata nóma chèl argómèet; ol virus.
Li spiegaziù, de chìi ca ai se nè 'ntènt dèla malatìa e sǜ 'ndèli sṍi conseguensi par la gèet, li trasmét nóma ansia.
Ol telefòn al tée compagnia par vès meno da parlóor.
Paròli par tirà sü ol moràal, batüdi par schersàa coi amìis e parèec’, ma deréet ai "te vedarée ca la finisarà debòt", l'angósa la se fà sintìi sèmpri pǜsé.
'Na rógia la pàsa a pröof ala la cà e ai pràac’ dè Cà di Cup, pò la và itè 'ndèl bósch gió vèrs ol Liri.
Chiló póoca acqua la va réet al sentéer par Cà di Mangii.
Ol pà ala lüus dèla domàa a bunura l'è 'ndàc' a da rigola ali vàchi.
'Ncöö lüu làdè finìi 'n canal pìscen , iscé 'l se portàat réet ol disnàa e mi prǜma dè 'ndàa a scṍla ndóo a töo ol làc’.
Mi fóo già la tèrsa elementàar gió al piàa.
A tórnàa 'n réet, iló sü 'ndèl sentéer, me blòchi: 'n gròs vèrom nìgro l'è iló mèz 'nbosolàat ca'l tée tǜt ol pasàc'.
Al me vée èn mèet Pinocchio ca l'incùntra 'n serpènt e al lè zómpa ià con 'n sàlt.
Al vedi sgambetàa cola cràpa 'ndèla pàlta da l'òtra pàart.
Iscé, mi fǜrba, al sàlti ca ià 'l bìs ma fóo ol gìr, de sùra, trà i ghislù.
I grüp de WhatsApp ai ne cünta sü e ai ne fà idìi de tüti li sort: róbi grevi o da grignàa, discórs lengéer o 'mpegnatìif...
Am se contènta dè chèsto cal par dè vès tüc' 'nsèma, 'ndèn solènch unèch par chi ca iè apröof.
Pasàat Ca di Minòc vedi ruàa sǜ dala Tasèra ol Carlo, chal fà già la quinta, la mia amìiśa Gina e ol sò cüśìn.
A Ca di Mói fóo par salüdài ma la Gina la me fà: "ven fìna àli Fópi pò te 'ndée par Albosagia Végia, Ca dol Péna e da iló al Piaz."
Mi céti. 'Ntàat ca se grigna e se schersa èn sè sü àli Fópi e diśi: "vegni fìna a Nèmbro e pasi da Bricéra par ruàa al Piaz".
Lóor i và a San Salvadù e mi 'ndóo par ol bósch.
Al véegió niòli sèmpri pǜsé scüri, al se viagió a piṍof, mi vedi ca l'ùra dè saltafó 'ndèl pràat, 'nvéci senti rümóor cóma dè'n fiǜm piee de acqua... o iè óos?
Ol sentéer al cumincia a vignìi èn gió. Cunfüsa sò ca pǜ 'nghée ca sóo.
La magàda l'è nóma 'na credènsa, ma… mi me gìri e torni 'nrèet 'ndèla scighèra.
'Ndóo 'ngiò dè bòt vèrs Féit, li Valmàni e pó Sant’ Antoni e li Fópi; gió amò fìna a Ca di Mói 'ndua ciapi sü la mülatiera ca conosevi bée: Taré, Rusulii, Ca di Rütech, Mantegù, l’Acqua Nigra e bindìna al Piaz.
Pìachi quai làgrimi denàz àla màma. Ol dì réet dendomàa 'l sentéer balòos l'è pulìit e lüminóos par ol sùul.
Dal chighèt di prǜm dì, 'ndua tüc' i va a fà spesa fó de merèt ai süpermercac', se pasa al coràgio di balcù cai canta.
Am vìt ontera chìi tacàac' de cà, me ósa ol beśógn de ringraziàa chìi ca ai se triga ca e ai me porta da vìif e i me cüra.
Al mè balcù 'l crès 'na prolunga: la vìta l'è ca pǜ sóspéśa cóma al inizi dèla pandemia, la siguìta e la ciacöola 'ndèl silènsi.
La vistiziù dol bósch l'è lónga 'na quarantena.
A fìi dè feorèer l'è tǜt biót e ol sṍl de la tèera al se fàidii: dòss e vai, tazei de pastüra, mürachi cuèrciadi dè müsc' e sàs spars.
Bióc' tösch dè castàa e gióen rugói daparlóor, nìsc, bedóli, póoch làres e gròś cèrfói dè colèr.
Ràar pèsc pìscen i lüsìs trà tàati sfümadüri de colóor.
Mi e i mée amìis 'n trua zeneòr, bróchi e ràm sèch par fàsü 'n muntù 'ndèla sèlva.
Stàsìra am pìza 'l grànt paiarṍl dè Carneval véc' e'm bala tǜc' 'ntóren.
Pò li piànti li sè 'mpinìs dè fói e èn aprìl lè 'mpiasé 'ndàité par ol bósch 'ndùa i animài ai se piaca ma tè'i sèntet e iscé ai te fà compagnia.
I regòrc' dol pasàat l'è vìta véra ca la fàc' strada coi cambiamèec' ca ghè stàc' èn püsé dè mèz sécol, fìna a chèsto dì dè 'ncöö ca lè da pùura. Al me porta dala fàcela realtà di iéer a chèla fadigósa dè 'ncöö.
Am lagarà 'mprèsi 'ndèla Tèera li tór dè Babele dol tèep dèl Antropocene.
'Mèz ala sèlva di Strèpaz ghè 'na sciareśèra grànda ca la dà i sṍö frǜc' rusìsc ai banderàai dèla cuntràda ca 'ntàac' ai rampéga sǜ 'ndi véc’ ràm 'ndèl mìis dè mac’.
Pǜsé èn là ghè 'na pìscena sorgènt ca la fà 'na póza piena de crapù ca dala gnàda papolègna i và vèrs la vìta da rana.
Pòoch dòpo al sè fà 'na rógia e ach 'n lavatòi, parché chèst'acqua tìveda la gela mài.
Màar dè rǜut, desèrt 'nvéci dè bósch, móntàgni sventradi, rèsc' de òs dè animài e dè óm cunciàac' èn schiavitü.
Li scìmi dèla mia vàl li fà idìi i vansaröi di vendüui ca iè iló da sempre e i crapù ai ghé ca pǜ gió 'ndèla póza dèla sèlva; li rani iè 'ndàci.
Ol 16 de mac’ 1959 l'è ignüut 'l Berto di Vitóor col càr. Ol fée l'è tàat e ol mǜl al se 'mpunta.
A vignìi èn sǜ dal Baitèl l'è ruàat 'n tempóràal. 'L vèet l'è fòrt, al sbüsa ol càr e àa 'l mǜl 'l fà ca pǜ fadìga e dapè al se més a tiràa.
'L me sbüsa àa mì cal me pàr dè ulàa, ma però óo àach 'n pìt de pùra.
Ma urìit la bìśacia di véec' e iscé ma finìit de trigàs.
Sórbóli, fàci da róbi miga giüsti, li 'ntàca ol Mónt, li ghè gira atóren e ai lè sufuca.
Tochéi dè vìta, sènsa còrp, riulüzionari, i fà pèert la sicümèra e ai se sirvìs dè nùu.
'Ncöö sóo 'ndàcia 'ndèla vìgna a mondàa cola àva.
Lée la strèpa la gramìgna dai tartìfoi mi la vìdola sé no la rampéga sǜ 'ndèla vìit e dòpo se ghè rua ca pǜ a tṍla ià sènsa rivinàa l'ǜa.
Al dopomesdì 'n và àli rogaziù.
Èn gìr par i sentéer di pràac’ ol prèvet al tràfó l'acqua sànta.
Am prega par vìch 'mbèlpóo de fée dai pràac' e tàac' frǜc' dala tèera e par fàa ca li vàchi li rèsti ca stérli.
La Madóna di nòś véc’ la ghà 'l cṍör 'nfilsàat dala spada.
Deréet ali palpébri sbaśàdi la tragedia par la mòrt dol Fiṍl, la trepidaziù par la sòort di òtri sṍö fiöi, ma àa ol regòrd gioióos dol pàart e la trasparensa dèla sùa promèsa.
Ciami àva l'ǜnega nòna ca óo cunusüut. Ol Marii di Cùp (1879+1972).
La caśàda desfàcia da l'emigraziù di fradéi; dói guèri mondiai, ol matrimoni e sés fiöi.
'Na fiṍla la se spósa debòt, dói li và a sèrva dai sciór èn cità; dùu màs-c' soldac' e pò èn guèra; ol sò óm lè mṍr debòt.
Cola la fiṍla pǜsé gióena la tira inàaz la cà e ai lavora la tèera; vigni, pràac' càap e magènch.
Pò la vée vegia; con 'ntóren fiöi e neùuc'.
L'è bàsa dè statǜra, dulsa 'ndéli fórmi redóndi e forta 'ndèl'espressiù dèla fàcia.
Póchi paròli e tàat laóoràa, discreziù 'ndi aféc' e tàata crèdensa 'ndèl Signóor ca la ghà dàc' la forsa par tignìi bòta da 'ndàa inàaz cola lónga vìta. ...fémni ca li sà stàa ité 'ndèla Crisi e 'ndà inàaz...
Il bosco in quarantena
Le mucche pascolano tra le Piani e l'Aial dèla Caòra. Femmine ingombranti e leggiadre nel bosco dei colori.
Da sole, tornano alla stalla per la mungitura.
Qualche manzetta si attarda.
Noi ragazzi, come piccoli Tarzan, ci appendiamo ai rami bassi dei larici e voliamo per poi tuffarci, temerari, tra cespugli di rododendro.
Il 23 febbraio 2020 scatta l’emergenza corona virus.
La fragilità e l’impotenza irrompono nella nostra vita e ne siamo frastornati.
Il dolore e la morte ci passano vicine, parenti e amici si ammalano, qualcuno muore e non possiamo accoglierli né accompagnarli. Siamo confinati in casa per legge.
Stupore e pietà si dilatano dalle case a ospedali e obitori, nelle residenze sanitarie e nelle strade vuote delle città e dei paesi.
Il bosco è un villaggio della fantasia che diventa realtà.
Facciamo a gara a scegliere il cerchio di castagni più grande per farne la nostra casa.
Cocci di stoviglie, frammenti di vetro colorato, scatole di latta, pigne e sassi dalle forme strane sono le nostre suppellettili.
Raccogliamo legnetti e recintiamo un piccolo orto.
La terra di castagno è buona e come per magia i tre fagioli seminati spuntano e si allungano sulla frasca.
Antichi gesti di roncola e il giovane nocciolo diventa una bambolina; la vestiamo con le larghe foglie di castagno ritagliate, cucite con fili d’erba e decorate dei teneri fiori della selva.
La televisione è troppo accesa e tratta un solo argomento. Le spiegazioni degli esperti, sulla malattia e sulle sue conseguenze nella società, trasmettono disagio.
Il telefono attenua la solitudine.
Parole incoraggianti, battute scherzose con amici e parenti, ma dietro i “vedrai che finirà presto”, l’angoscia si fa sempre più strisciante.
Un ruscello lambisce La Cà e i prati di Cà di Cup, entra nel bosco verso il Liri.
Qui poca acqua devia e segue il sentiero per Cà di Mangii.
Il babbo all’alba è andato a regolare le mucche.
Oggi deve completare il piccolo canale, così si è portato il desinare e io, prima di andare a scuola, vado a prendere il latte.
Io faccio già la terza elementare.
Al ritorno, a un certo punto, mi blocco: una grossa biscia nera è lì, arrotolata nel bel mezzo del sentiero e lo occupa tutto.
Mi viene in mente Pinocchio che incontra il serpente e lo scavalca con un salto.
Lo vedo sgambettare con la testa nel fango dall’altra parte.
Io però, furba, non salto, lo aggiro tra i mirtilli, il serpente.
I gruppi WhatsApp imperversano con ogni sorta di commento e immagini: gravi o ironici, leggeri o impegnativi…
Ci si accontenta di questa parvenza di comunità, nella nostalgia della vicinanza reale.
Passato Ca di Minòc vedo salire dalla Tasèra il Carlo, quello di quinta, la mia amica Gina e suo cugino.
A Ca di Mói, faccio per salutarli, ma la Gina mi fa: vieni fino alle Fópi poi vai a Albosagia e Ca dol Péna e da lì al Piaz.
Io accetto. Si ride e si scherza in piccole sfide, così alle Fópi dico: vengo fino a Nèmbro e passo da Bricéra.
Loro vanno a San Salvadù e io prendo per il bosco.
Scendono nuvole sempre più scure, comincia a piovere, io non vedo l’ora di sbucare nel prato, invece sento rumori come di fiume in piena…o sono voci?
E il sentiero comincia a scendere. Confusa non so più dove sono.
La Magada è solo una leggenda, ma… io mi volto e torno indietro nella nebbia.
Scendo di corsa verso Féit, le Valmàni e poi Sant’ Antoni e le Fópi; a Ca di Mói riprendo la salita per la mulattiera ben conosciuta: Taré, Rusulii, Ca di Rütech, Mantegù, l’Acqua Nigra e finalmente al Piaz.
Nascondo qualche lacrima davanti alla mamma. L’indomani il sentiero ingannatore è pulito e luminoso di sole.
Dal panico dei primi giorni con assalto ai supermercati al coraggio dei balconi che cantano.
Benevoli coi vicini, gridiamo il bisogno e la gratitudine a chi non si ferma e ci nutre e ci cura.
Al mio balcone cresce una prolunga: la vita non è più sospesa come all’inizio della pandemia, continua e comunica nel silenzio.
La vestizione del bosco è lunga una quarantena.
A fine di febbraio è tutto nudo e il suolo si mostra: dossi e convalli, radure e sassaie coperte di muschi, massi erranti.
Spogli girotondi di castagni e solitari quercioli, ontani e betulle, pochi larici e grossi cespugli di nocciolo.
Rari piccoli abeti brillano tra le molteplici sfumature. Io e gli amici troviamo arbusti e rami secchi.
Ne facciamo un mucchio nella selva. Questa sera accendiamo il grande falò del Carneval di véc’ e balliamo tutto intorno.
Poi gli alberi si riempiono di foglie e ad aprile il bosco è un mistero accogliente dove gli animali si nascondono ma li senti e ti fanno compagnia.
Il passato dei ricordi è vita vera che percorre i mutamenti di oltre mezzo secolo, fino a quest’oggi inquietante.
Mi conduce dalla semplice concretezza di ieri alla faticosa ricerca di un senso.
Lasceremo impresse nella Terra le torri di Babele dell’Antropocene.
Al centro della selva dei Strepaz il grande ciliegio dispensa i suoi frutti rosei ai monelli della contrada che a frotte si arrampicano sui vecchi rami, nel mese di maggio.
Più in là, una piccola sorgente si fa pozza e i girini brulicano dal nido gelatinoso verso la vita.
Poco dopo è ruscello e lavatoio, perché quest’acqua tiepida non gela mai.
Mari di spazzatura, deserti invece di foreste, montagne sventrate, fossili di animali e di uomini ridotti in schiavitù.
Le cime della mia valle mostrano rimasugli dei loro ghiacciai millenari e i girini non ci sono più nella pozza della selva.
16 maggio 1959. È venuto il Berto dei Vitóor col carro.
Il fieno è tanto e il mulo si impunta. A venire in su dal Baitel è arrivato il temporale. Il vento è forte e spinge il carro e il mulo non fa più fatica e di nuovo si mette a tirare.
Spinge anche me e mi pare di volare però ho anche un po’ paura.
Abbiamo aperto l’otre dei venti ed è finita la bonaccia. Turbini di squilibrio contagiano il pianeta e lo percorrono. Frazioni di vita, inconsistenti e ribelli, umiliano l’umana sicuméra e si servono di noi.
Oggi sono andata nella vigna a mondare con la nonna. Lei toglie la gramigna dalle patate io la vidòla se no si arrampica sulla vite e dopo non si può più togliere senza rovinare l’uva.
Al pomeriggio andiamo alle Rogazioni. In giro per i sentieri dei prati, il prete sparge l’acqua santa.
Preghiamo per avere tanto fieno e i frutti della terra e per le mucche che non vanno sterili.
La Madonna dei nostri vecchi ha il cuore trafitto dalla spada.
Dietro le palpebre abbassate la tragedia per la morte del Figlio, la trepidazione per la sorte degli altri suoi figli, ma anche il ricordo gioioso del parto e la trasparenza della sua promessa.
Chiamo ava l’unica nonna che ho conosciuto.
Marii di Cup (1879+1972).
La famiglia dissolta dall’emigrazione dei fratelli; due guerre mondiali, il matrimonio e sei figli.
Una figlia si sposa presto, due al servizio dei signori in città; due maschi soldati e poi in guerra; il marito muore presto.
Con la figlia più giovane tira avanti la casa e la campagna. Poi invecchia; figli e nipoti intorno.
È bassa di statura, dolce nelle forme rotonde e severa nell’espressione del volto.
Poche parole e tanto lavoro, riserbo negli affetti e una fede incrollabile che è la resistenza di una vita lunga.
…le Donne che sanno stare dentro la Crisi e andare oltre…
